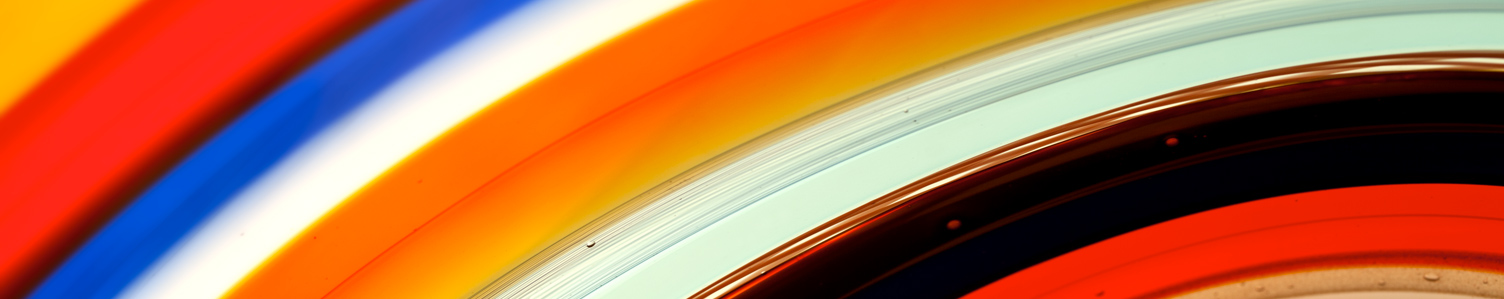I maestri del vetro parlano tra loro in modo spesso incomprensibile per chi non conosce il gergo vetrario. Ogni fase del loro lavoro, ogni utensile, ogni tipologia di vetro ha un nome veneziano che si tramanda di padre in figlio fin dalla nascita della tradizione vetraria muranese.
Oggi, molti termini sono caduti in disuso, ma la maggior parte rimane tuttora utilizzata in fornace. Questo piccolo dizionario vuole essere d’aiuto per comprendere a cosa si riferisce una certa parola.
APPLICAZIONI A CALDO
Tecnica molto usata a Murano consistente nell’applicazione, durante la lavorazione dell’oggetto, di fili, bordi, manici ecc. di varia foggia, colore e dimensione. Il risultato è da considerarsi esteticamente valido quando tali applicazioni risultano regolari e precise.
AVVENTURINA
Pasta vitrea particolarmente pregiata, inventata dai vetrai muranesi nella prima metà del XVII secolo e così chiamata perché il suo ottenimento, anche per il più esperto vetraio, era incerto e difficile, era una “avventura”. La preparazione della “avventurina” lunga e delicata, alla conclusione della quale si formano all’interno della massa vitrea piccoli cristalli di rame lamellari e lucenti (“stelle”, da cui il nome “stellaria”, con cui pure venne indicata in passato) è sempre stata nel corso dei secoli segreto di pochi abili tecnici compositori. Viene estratta in blocchi dal forno, già lentamente raffreddato, e la sua rifusione può seriamente pregiudicare il suo caratteristico aspetto. Viene quindi tagliata a freddo al pari di una pietra dura o lavorata a caldo con particolari accorgimenti. L’avventurina normale trattata con rame ha un colore brunastro e con “stelle”, mentre una qualità ancora più pregiata (verderame) acquista una tonalità verdastra di ottimo effetto.
BALLOTTÒN
Stampo in metallo con effetto a rilievi incrociati sul vetro. Lo stampo contiene all’interno delle “punte” a forma di piccola piramide a base quadrata che, nella soffiatura, danno per l’appunto un effetto di rilievo incrociato. Ricoprendo una péa (v.) stampata a ballottòn con una coperta (v.) di tipo sommerso (v.) si ottiene l’effetto bullicante o “a bolle”, consistente in una miriade di piccolissime bolle d’aria comprese tra due strati di vetro.
BOLLE (Bullicante)
Particolare effetto decorativo utilizzato nei vetri a grosso spessore e consistente in una miriade di “bolle” , grandi o piccole, disposte a strati sovrapposti all’interno della parete vitrea. Si ottiene in due modi: nel primo rotolando il vetro in lavorazione su di un piano metallico munito di piccole “punte” cosicché, imprimendo una depressione sul vetro allo stato pastoso risulta con “fori” che verranno successivamente “ricoperti” con un nuovo strato di vetro. Resta, quindi, “imprigionata” una bolla d’aria vera e propria in corrispondenza di ciascun “foro”. Un secondo sistema consiste in uno stampo troncoconico munito all’interno di “punte “ e nel quale viene soffiato il vetro che risulterà “ frato” . Una successiva ricopertura in vetro trasparente farà apparire le “ bolle” stesse (v. anche Ballottòn).
CANNE VITREE
Semilavorato consistente in una “bacchetta” vitrea massiccia o forata e successivamente tagliata in segmenti di varia lunghezza. E’ già documentato nella vetraria muranese del XV secolo ove si parla del maestro “canér” (cannaio). La procedura esecutiva è simile a quella per la produzione delle perle (v.) Le canne vengono usate oltre che per la produzione di conterie, delle “perle a lume” anche nella lavorazione in fornace accostando, p. e., le canne parallelamente o sezionandole e raccogliendole poi a caldo con vetro allo stato pastoso. (vedi anche “murrine”).
COLORI IN FÒGO
Locuzione ancora in uso a Murano e che sta ad indicare un vetro colorato in fusione mediante ossidi o sali minerali.
COTIZZO
(Cotizza o cotticcia, cioè non del tutto cotta). Coacervo di grossi pezzi di vetro, usualmente della misura di ciottoli di fiume. Il cotizzo si ottiene anche gettando nelle conche (v.) il vetro fuso estratto dai crogioli, lasciandolo indi raffreddare. Il vetro, nel processo di raffreddamento, si contrae e si spezza in grossi pezzi. Il cotizzo, come rottame di vetro, viene spesso riusato quale catalizzatore nella miscela da vetro. Il Capitolare della Vetraria Muranese del 1766 parla di “cotizzi in vetro e cristallo, che così si chiama la massa informe del vetro che si cava dal vaso” (v. Mariegola).
CRISTALLO (Cristallo Veneziano)
Vetro incolore e terso, ottenuto per la prima volta attorno alla metà del XV secolo dal vetraio muranese Angelo Barovier, oltre che con la decolorazione mediante il manganese, già prima praticata, anche con la depurazione, cui veniva sottoposta la cenere fondente, e con speciali procedimenti applicati alla condotta della fusione. Il cristallo veneziano, di tipo sodico, è adatto, a differenza del più tardo cristallo boemo, alla potassa, ed inglese, al piombo, ad una lunga e complessa lavorazione manuale da parte del maestro vetraio.
FENÌCIO
Tipo di decorazione ottenuta a caldo, applicando attorno alle pareti dei soffiati, dei fili vitrei, che poi vengono “pettinati” con uno speciale strumento, così da ottenere dei festoni ripetuti. Questi, scaldati e soffiati ulteriormente, possono essere inglobati nella parete del vaso, che risulta così liscia. Questa tecnica decorativa venne introdotta nelle vetrerie muranesi alla fine del XVI secolo o nel XVII secolo ma non sappiamo come allora venisse denominata. Il termine “fenicio” venne adottato nella seconda metà del XIX secolo per la presenza di simili decorazioni nei vetri pre-romani fenici ed egiziani, ma si usò allora pure il termine “graffito”, (v. vetri “piumati” e a “pettine”) poi abbandonato.
FILIGRANA
Raffinata tecnica decorativa a caldo, inventata a Murano nella prima metà del XVI secolo. La complessa lavorazione dei soffiati a “filigrana” prevede l’utilizzo di bacchette di cristallo, precedentemente preparate con all’interno fili vitrei in “lattimo” o colorati, lisci o a spirale. Si distinguono la filigrana a “reticello”, con una delicata trama a rete all’interno della parete di cristallo; la filigrana a “retortoli”, a fili variamente ritorti a spirale, chiamata anche “zanfirico”, dal nome dell’antiquario veneziano Antonio Sanquirico, che commissionò nella prima metà del XIX secolo numerose copie di vetri antichi fabbricati con questa tecnica. Negli ultimi decenni sono stati ideati a Murano nuovi originali tipi di filigrana. Viene chiamata “mezza filigrana” la decorazione a canne parallele, a filo interno diretto, lavorata in modo tale che assume andamento diagonale. Già verso la metà del XVI secolo, come ci informa la “Mariegola dei Fioleri” (v.), si lavorano vetri a “redexello” o a “retortoli” (reticello e ritorti). La filigrana o reticello si ottiene mediante sottili canne in vetro con al loro interno fili di vetro opaco, generalmente bianco. Queste canne (simili a matite) vengono accostate le une alle altre su di una piastra refrattaria, quindi riscaldate al fuoco della fornace finché si fondono e si uniscono le une le altre. La “piastra” così ottenuta viene successivamente “avvolta” attorno ad un cilindro di vetro trasparente e incandescente, cosicché risulteranno visibili i soli fili interni (bianchi o colorati). Si procede poi alla normale soffiatura e formatura degli oggetti vari (vasi, coppe ecc.). Nel caso del” reticello” classico, l’operazione sopra descritta viene compiuta in due fasi successive e sempre a caldo finché i fili si incrociano tra loro: questa esecuzione richiede una notevole perizia tecnica ed un’elevata sensibilità artistica.
FOGLIA D'ORO E D'ARGENTO
Sottilissimo riquadro d’oro puro, di norma nelle misure di cm. 8×8 che viene “raccolto” dal vetro ancora allo stato pastoso nella fase iniziale di lavorazione. L’oro può essere poi ricoperto da un ulteriore strato vitreo trasparente. Se il vetro viene soffiato la “foglia” d’oro si frantuma in un suggestivo effetto di “pulviscolo aurato”.
I più antichi vetri muranesi a foglia d’oro che conosciamo risalgono alla seconda metà del sec. XV. Nel XIX secolo si usa anche la foglia in argento che deve per altro essere “ricoperta” con altro strato di vetro onde evitare ossidazioni indesiderate.
GHIACCIO o CRAQUELE
Decorazione consistente in un’apparente crepatura della parete esterna di vetri soffiati, ottenuta immergendoli in acqua nel corso della lavorazione. La reazione che ne deriva, sorta di “raggrinzimento”, produce appunto un effetto “a ghiaccio”. Tale lavorazione è nota almeno dal XVIII secolo.
INCALMO
Difficile e tipica tecnica muranese consistente nella saldatura a caldo di due soffiati aperti, generalmente di colore diverso, lungo i loro due orli di uguale circonferenza, così da ottenere in uno stesso oggetto zone coloristiche differenziate.
INCAMICIATO
Vetro ricoperto di un sottile strato vitreo di diverso colore. Molto usato nel Novecento è, in sostanza, una variante del cd. “vetro doublè”.
INCISIONE
L’incisione a punta di diamante venne introdotta a Murano per la prima volta da Vincenzo d’Angelo su specchi nel 1534 o 1535 e lo stesso Vincenzo ottenne nel 1549 un “privilegio” per l’incisione a punta di diamante su specchi e soffiati. Con la vetraria alla “façon de Venise” venne poi diffusa in tutta Europa, specialmente in Tirolo e nei Paesi Bassi. L’incisione con una ruotina di pietra abrasiva o metallo deriva dalla incisione delle pietre dure e venne applicata con splendidi risultati in Germania e Boemia nel sec. XVII. Alla fine di quel secolo venne introdotta anche a Venezia con l’arrivo di incisori tedeschi.
MACIE (maciètte, màcie fine)
Frammenti di vetro, in genere colorati, che, avvolti attorno ad un vetro bianco, conferiscono al medesimo il colore dei frammenti (di qui il termine macia = macchia). Maciette, macie fini = macchie ancora più fini.
MAESTRO
Termine recente che sta ad indicare l’operaio più abile della équipe dei vetrai d’arte e responsabile del buon funzionamento della piazza (v.). A lui di regola, il datore di lavoro delega una serie di poteri esecutivi nella piazza stessa. In antico era detto scagner (v.)
MORÌSE 0 MORISÉTTE
Tipica decorazione muranese a forma ondulata, eseguita partendo da un filo di vetro caldo applicato su di una superficie e “pizzicandolo” con le borselle di pissegàr (v.). In sostanza è un cordoncino di vetro deposto e sagomato sull’oggetto in corso di lavoro e dal caratteristico andamento ondulato.
PAPAÒR
Piccolo cilindro in vetro, spesso con bacinella sottostante, e in grado di sostenere una candela nei bracci dei lampadari o dei candelieri.
PÈA
Detta anche pallina (v.). E’ la fase iniziale di un qualsiasi oggetto cavo in vetro. Etimologicamente significa “pera” perchè di quel frutto ha la forma. Attaccata alla canna la pèa viene marmorizzata (v.), magiossata (v.) all’occorrenza.
PIAZZA
Nella fornace classica muranese sta ad indicare squadra (da quattro a otto uomini) e tutto quanto è necessario per produrre un oggetto. E’ in realtà l’unità produttiva fondamentale e autonoma, in grado di eseguire un “pezzo” dall’inizio alla completa realizzazione. Ne è a capo il “maestro” che ha una sorta di responsabilità (e autori- tà) delegata da parte della direzione aziendale.
PIUMÀTI
Vetri con particolare decorazione, detta anche “a pettine” o “a penne” o anche “graffito” e “fenicio”. Di origine antica, la decorazione fu usata dai Romani e, dal secolo XVI, dai veneziani.
PONTÉLLO
Canne di ferro massiccio, lunghe circa 140 cm. e del diametro tra i 10 e i 30 mm. con le quali si “attacca” un oggetto in fase di lavorazione. Il termine muranese passò ben presto in Francia (pontil) e in Inghilterra (Punty).
PULEGÒSO (dal termine gergale "púlega" = bollicina)
Vetro dalla superficie scabra, semi opaco o traslucido, formato da minutissime bollicine ottenute con particolari accorgimenti (bicarbonato di sodio, petrolio). Invenzione moderna, tipica degli anni Venti e attribuita a Napoleone Martinuzzi.
REDEXÈLLO
Secondo notizie desunte dalla “Mariegola” (statuto dell’arte) dei vetrai di Murano, verso la metà del Cinquecento si lavoravano nelle fornaci dell’isola vetri soffiati sottili a “redexello”, così detti perché ricordavano la rete dei pescatori. Forse l’idea di questa tecnica è proprio nata dall’osservazione di questo strumento di certo familiare a gente di mare come i veneziani. Si tratta di una esecuzione simile alla filigrana (v.) con canne tonde a filo interno bianco opaco “girate” in senso opposto tra loro e quindi “incrociate” durante la lavorazione a caldo mediante una tecnica difficile e ardita. Le forme semplicissime consentono all’amatore di godere completamente e senza barriere formali questo straordinario “tessuto di vetro”.
RIGADIN
Sottili costolature ottenute con la soffiatura in uno stampo aperto di un vetro, il quale può venire sottoposto, ancora caldo, ad una torsione (rigadìn ritorto).
SBRUFFO
Si tratta di un “soffiata” di vetro molto sottile e di norma colorato che viene usato successivamente in sottili lamelle o scaglie per decorazione a caldo di oggetti vari.
SERVENTE
Nella gerarchia della piazza (v.) del vetro artistico è il primo aiutante del maestro e suo diretto collaboratore. Esplica mansioni di elevato contenuto tecnico e artistico ed è in grado, talvolta, di sostituire il maestro stesso.
SERVENTÌN
Nella gerarchia del vetro artistico muranese è il terzo componente della piazza, dopo il maestro e il servente.
SOFFIATURA A BOCCA
Costituisce la tecnica vetraria “classica” quando si vuole ottenere un oggetto cavo. La modellazione di un oggetto cavo viene effettuata dal “maestro” coadiuvato dai suoi aiutanti con l’uso della canna da soffio (v.) di “borselle” (v.) e “tagianti” (v.). La soffiatura costituisce una delle invenzioni più rivoluzionarie nella tecnica vetraria e la sua scoperta si fa risalire tra il I secolo a. C. e il 1 secolo d. C., forse in Siria. La soffiatura del vetro inventata nei centri vetrari del vicino Oriente mediterraneo ebbe larghissima applicazione nelle vetrarie romane, islamiche e veneziane. La soffiatura avviene oggi non solo manualmente come per il vetro d’arte ma anche con mac- chine automatiche.
SOFFIATURA A STAMPO
Tecnica manuale in uso tuttora a Murano e risalente sin dall’età romana. Consiste nella soffiatura di una “péa” (v.) in uno stampo che può essere costituito da due o tre parti incernierate. A Murano, di solito, in legno di ciliegio. Oggi si usa anche la ghisa e altri metalli. Lo stampo può essere anche composto da un unico pezzo troncoconico usualmente di bronzo e ottone. Il primo tipo di stampo conferisce all’oggetto una forma definitiva mentre il secondo tipo imprime un motivo decorativo sulla parte soffiata, che sarà successivamente modellata.
STAMPO
Utensile concavo, in ferro o, in antico, in bronzo, nel quale si soffia la péa (v.) che dilatandosi viene modellata. Vari sono i tipi di stampo usati; ricordiamo quello a coste o rigature verticali, quello a ballottòn (v.) quello a “serci” o a cerchi orizzontali. Si dice stampo “a fermo” quando, per il tipo di costolature interne, non è possibile “girare” la péa nello stampo.
TÉMPERA
Termine muranese improprio per indicare la “ricottura” del vetro o il forno dove avviene tale operazione.
VETRO A "CANNE"
E’ una variante, tutta muranese, delle murrine (v.). Invece di minuscoli tasselli in vetro si usano in questo caso delle “canne” sia cilindriche e massicce che piatte. Accostate tra di loro, con combinazioni coloristiche diverse, e successivamente fuse e soffiate onde ottenere un vaso, un’anfora, una coppa, sono di particolare pregìo e per l’effetto finale e per l’insita difficoltà esecutiva.
VETRO A GHIACCIO o CRAQUELE
Decorazione consistente in un’apparente crepatura della parete dei soffiati, ottenuta immergendoli nel corso della lavorazione, ancora caldi, in acqua.
VETRO CRAQUELÉ
Effetto speciale sul vetro consistente in una apparente “crepatura” della parete vitrea. E’ un procedimento similare al vetro “a ghiaccio” (v.) e molto usato nell’Ottocento in Francia.
VETRO INCAMICIATO
Detto anche” sommerso”, è una tecnica decorativa che permette di ottenere in uno stesso oggetto più strati sovrapposti, talvolta di colore diverso con suggestivi effetti cromatici. Il “sommerso” ebbe grande fortuna negli anni Trenta. Si ottiene immergendo il vetro di colore diverso. Il “vetro incamiciato” ha di norma strati più sottili rispetto al “sommerso”. In Francia tale tecnica, detta “doublè” (v.) o vetro raddoppiato, consentiva, con l’intaglio che raggiungeva il colore sottostante, effetti di notevole valore estetico.
VETRO "MURRINO" (mosaico a caldo)
Definizione impropria per descrivere una tipica lavorazione muranese risalente già alla vetraria classica Alessandrina. Consiste in una sorta di intarsio o di mosaico “a caldo”, cioè pezzetti di vetro, spesso modellati ad hoc, e fusi in modo che i vari tasselli, fondendosi, si saldino tra loro. Una tipica variante della murrina è il “millefiori” (v.) altrimenti detto “rosette” (v.). Tecnica decorativa di particolare difficoltà, praticata in epoca romana e recuperata a Murano all’inizio dell’ottavo decennio del XIX secolo presso la vetreria Salviati da Vincenzo Moretti. Il vetro-mosaico a millefiori si ottiene giustapponendo sezioni di canne vitree, recanti un motivo decorativo policromo all’interno, per tutta la loro lunghezza, e saldandole insieme al calore del forno. Sembra provenga dal termine latino “murrha” che stava ad indicare una pietra naturale misteriosa che emanava un soave profumo.
VETRO VENEZIANO
I suoi componenti sono essenzialmente il biossido di silicio come vetrificante e componente cristallina (costituita da sabbia di cava e in antico da ciottoli quarzo- si di fiume frantumati e polverizzati, i cd. “cógoli” (v.) e come fondente (un tempo fornito da cenere di piante litoranee come il cd “ròscano” (v.) e oggi mediante carbonato di sodio (ottenuto con il cd. processo Solvay) o carbonato di potassio. Viene usata anche la calce come “stabilizzante” oltre ad altre varie aggiunte di minerali vari con scopi “coloranti”, “decoloranti” “opacizzanti” e “affinanti” e altre sostanze ancora atte a conferire qualità particolari al vetro. Non è qui luogo per una più completa descrizione dei componenti ma ricordiamo che il vetro veneziano è un vetro “lungo”, cioè permane in condizioni di lavorabilità per un discreto intervallo temporale prima di essere riportato a contatto col fuoco della fornace per un nuovo “rammollimento”. Ciò permette complesse manipolazioni, aggiunte di altro vetro, “tagli a caldo”, tipiche caratteristiche della tradizione vetraria veneziana.